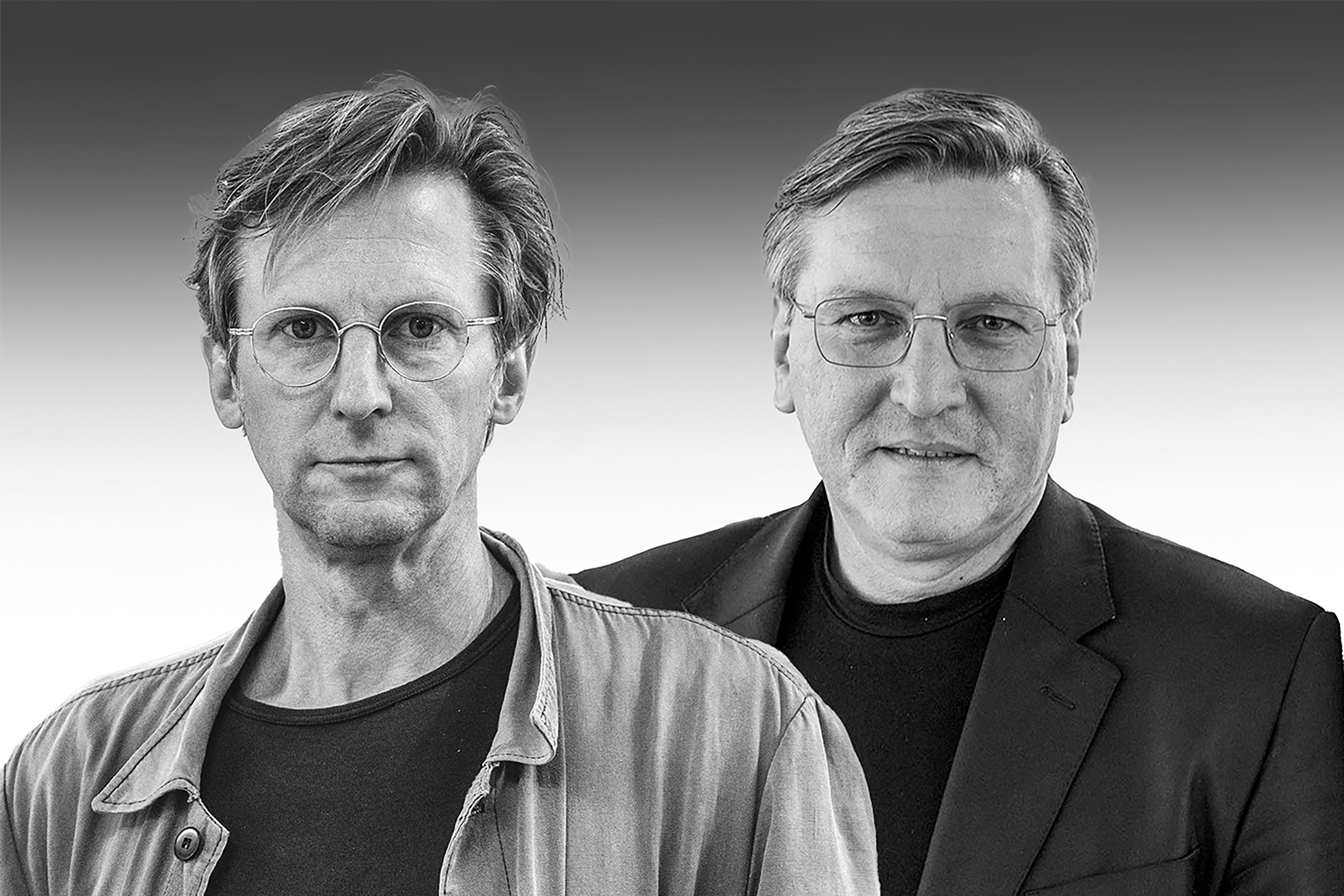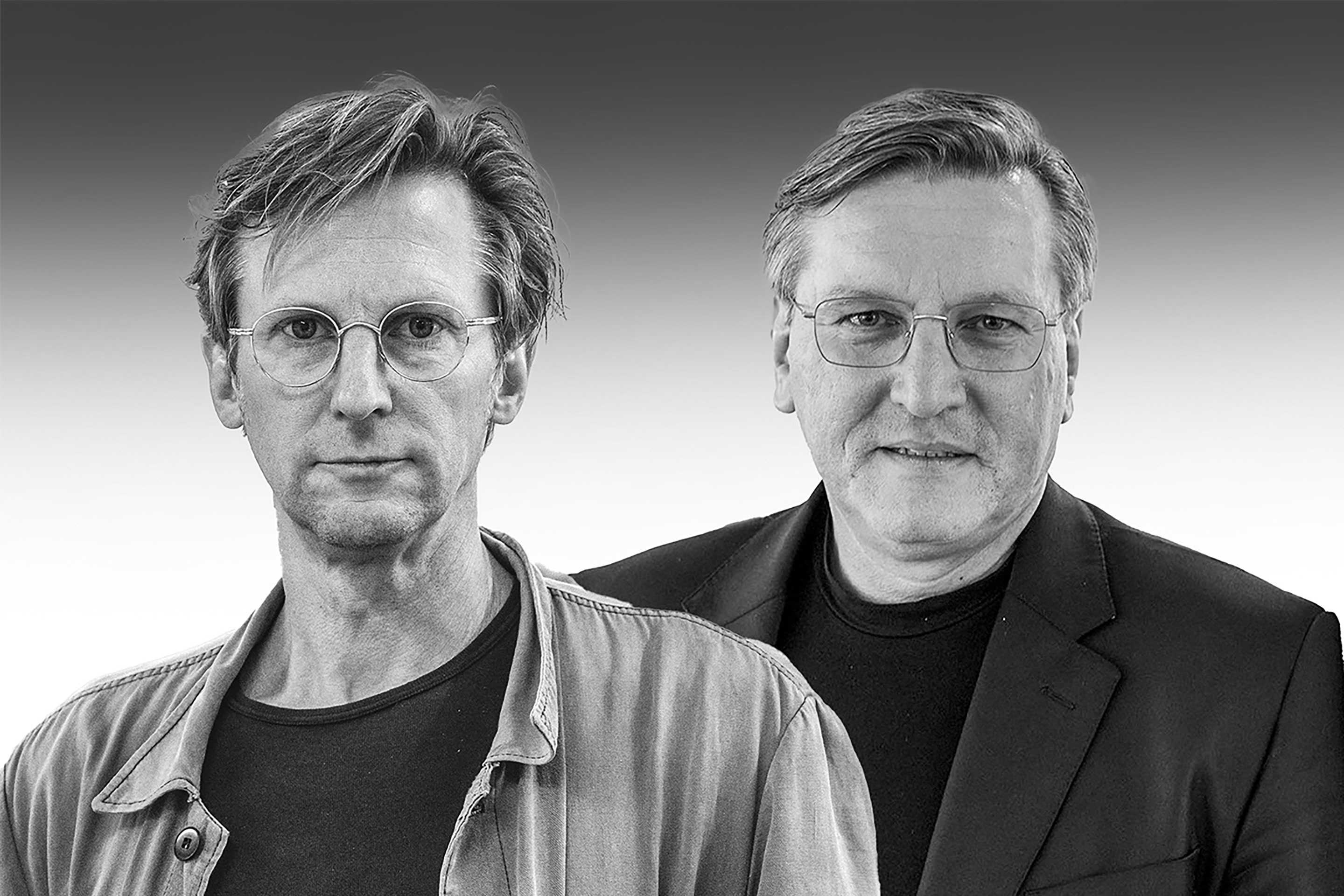
In autunno verrà assegnato, per la terza volta, il Premio Master Architettura della SIA. Promosso dalla SIA e dal Consiglio svizzero dell’architettura, il Premio offre una rassegna, unica nel suo genere, che illustra la qualità e i frutti della formazione offerta dalle scuole universitarie svizzere di architettura. Con Beat Waeber (ZHAW) e Christoph Gantenbein (ETH di Zurigo), entrambi membri del Consiglio dell’architettura, abbiamo parlato della nuova collaborazione intessuta tra università e scuole universitarie professionali.
Il Premio Master Architettura della SIA è un’iniziativa nata nel 2022 che ora coinvolge tutte e nove le scuole universitarie svizzere con un corso di laurea magistrale in architettura. È stata un’idea vincente?
Beat Waeber: Dal punto di vista della ZHAW, questo progetto che coinvolge anche le scuole universitarie professionali è un vero successo. Il Premio rende tangibili i frutti della formazione offerta a chi si iscrive al Master di architettura. Poter presentare, attraverso questo concorso, i risultati del nostro percorso di studi ci riempie di orgoglio. La mostra «Sign of the Times», allestita presso il Museo svizzero di architettura S AM di Basilea, presenta i progetti premiati negli scorsi due anni e offre uno spaccato di quelli che sono i temi, le questioni e gli approcci approfonditi dalle studentesse e dagli studenti nei propri lavori di Diploma.
Christoph Gantenbein: Io e Beat abbiamo un duplice ruolo in questa intervista, entrambi infatti rappresentiamo sia le nostre scuole sia il Consiglio dell’architettura, di cui siamo membri. Anche per il Consiglio il Premio è un grande successo. Essere già alla terza edizione e godere dell’appoggio compatto delle scuole universitarie è un segno concreto del fatto che questo organo funziona, come istituzione, ed è oggi un’associazione attiva. Non è un aspetto trascurabile, in periodi altalenanti come quello in cui viviamo. Di fatto, ogni rete di networking, in cui le persone hanno la possibilità di scambiarsi punti di vista e opinioni, contribuisce a infondere stabilità. Trovo importante che ciò avvenga anche nel campo dell’architettura.
C’è forse qualche altra proposta che il Consiglio dell’architettura vorrebbe presentare in relazione al Premio? Magari l'idea di lanciare anche un riconoscimento a livello di Bachelor?
Waeber: Il Premio Master della SIA è un pilastro portante del dibattito sulla qualità della formazione in architettura. Permettetemi un piccolo excursus: il Consiglio dell’architettura è stato fondato nel 2008 come piattaforma di discussione tra le università e le scuole universitarie professionali, con lo scopo di armonizzare l’insegnamento dell’architettura in Svizzera nel quadro del processo di Bologna e di definire i profili di competenza dei programmi di Bachelor e Master. Per rispecchiare il sistema educativo duale, oltre al livello Bachelor era necessario coordinare tra le università anche la formazione a livello Master. Oggi le università e le scuole universitarie professionali (SUP) offrono percorsi a entrambi i livelli. Risulta superata ormai anche la vecchia distinzione nel campo della ricerca, secondo la quale le SUP fanno ricerca applicata mentre le università si occupano della ricerca di base. Secondo la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 2015, la responsabilità per le SUP è condivisa da Confederazione e Cantoni. Ciò dà origine a diversi concetti formativi, sia in termini didattici che contenutistici. Appare quindi ancora più importante che il Consiglio dell’architettura promuova e sostenga nel settore il dibattito sulla formazione. Uno strumento valido è il confronto competitivo, come quello che prende forma nell’ambito del Premio Master Architettura della SIA. Poi si può anche riflettere sulla necessità di istituire anche un premio SIA per il Bachelor, sapendo però che i profili di competenza e i curricula delle SUP sono ancora troppo diversi tra loro per rendere possibile un paragone tra i compiti da svolgere e i progetti realizzati dalle studentesse e dagli studenti.
Gantenbein: In questo contesto l’ETH di Zurigo è in una posizione diversa rispetto alle scuole universitarie professionali: chi decide di studiare al Politecnico ha già conseguito un diploma di maturità e può così accedere direttamente agli studi. Tre anni sono un periodo troppo breve per maturare un proprio stile per quanto concerne l’espressione architettonica. Nelle SUP è diverso: lì spesso si iscrivono giovani professioniste e professionisti che hanno già fatto prima una formazione nel settore della costruzione. Il mondo dell’architettura si fa sempre più complesso. Ecco perché nutro alcune riserve su un percorso di studi che si fermi al Bachelor. Personalmente – e penso di poter parlare anche a nome dell’ETH di Zurigo – non sarei favorevole a celebrare la laurea triennale con un premio ad hoc. Piuttosto, incoraggerei le giovani leve a fare un po’ di pratica dopo il Bachelor, con un’esperienza lavorativa in uno studio, e poi a proseguire gli studi fino al conseguimento del Master. Nella nostra professione, il pensiero autonomo e critico è di importanza cruciale. A mio parere, questa capacità la si sviluppa solo con un Master.
Waeber: Sì, anche noi la pensiamo così. Il diploma di Bachelor dura sei semestri e vale come abilitazione professionale. Anche nelle SUP il ciclo completo di studi di architettura dura dieci semestri e include il Master.
Ciò che colpisce nei lavori presentati è che le giovani e i giovani architetti, in veste di autori, si spingono oltre l’«architettura degli oggetti», non solo nelle tematiche affrontate, ma anche nella modalità di rappresentazione scelte. È una tendenza generale nelle scuole? O sono le scuole a presentare per il concorso solo questo genere di lavori?
Waeber: Penso che i lavori rispecchino l’odierna cultura della costruzione, quella che viene insegnata oggi nelle scuole, la stessa che viene anche richiesta dalle studentesse e dagli studenti. La formazione in architettura ha vissuto una trasformazione. In seno al Consiglio dell’architettura abbiamo parlato a fondo del profilo professionale. Come centro di formazione per le architette e gli architetti, non solo dobbiamo confrontarci con l’attuale pratica professionale, dobbiamo anche confezionare un programma in cui risultino chiaramente le competenze che trasmetteremo nei prossimi cinque–dieci anni. I lavori presentati dalle studentesse e dagli studenti mostrano in modo esemplare che le questioni affrontate dall’architettura sono cambiate.
Questo approccio prepara chi studia ad affrontare la professione sul campo o si viene forse a creare un divario tra formazione e pratica?
Waeber: Alla luce dei cambiamenti climatici e delle alte percentuali di emissioni di CO2 prodotte dal settore della costruzione, oggi il settore interviene in modo ancora troppo circoscritto. Il tema dell’edilizia sostenibile dovrebbe essere una delle massime priorità in ogni scuola di architettura ed essere trasmesso alle studentesse e agli studenti da tante prospettive diverse. È la prassi dell’edilizia che dovrebbe seguire le scuole, e non viceversa. Vorrei citare un aforisma che Luigi Snozzi ha formulato alla metà degli anni Settanta: «Il giorno in cui i laureati non potranno più essere utilizzati negli uffici d’architettura, la scuola avrà fatto un grande passo in avanti»1. Trovo che sia un punto di vista ancora attuale. Il nostro compito non è soltanto quello di offrire alle nostre studentesse e ai nostri studenti una formazione che permetta loro di districarsi nel mondo professionale, dovremmo anche trasmettere loro la capacità di comprendere questioni e interrelazioni che vanno al di là della mera architettura. Nella nostra scuola di architettura, ad esempio, i lavori di Diploma sono strettamente legati ai progetti di ricerca condotti dall’istituto. Insegnamento e ricerca, quindi, si alimentano a vicenda. Inoltre, tutti i progetti presentati come lavori di Diploma sono individuali, sono le studentesse e gli studenti stessi a scegliere l’una o l’altra tematica. Gli interrogativi esplorati, perciò, sono un riflesso degli argomenti che la nostra scuola approfondisce sul piano della ricerca.
Gantenbein: Naturalmente, di pratica non ce n’è una sola: ora il profilo professionale si è fatto molteplice e variegato, di per sé quella di costruire non è che una delle tante opzioni possibili. Per questo è importante che la formazione rispecchi l’eterogeneità della professione. L’architetto in quanto tale nasce generalista. Con la formazione si apprende una metodologia con cui poter rispondere a complessi quesiti. Dieci o quindici anni fa non era così: allora gli interrogativi erano predefiniti e la soluzione, in un certo senso, era già data. Ma il nostro mondo ha assunto così tante sfaccettature… Già oggi, nei classici progetti di costruzione, io stesso mi vedo coinvolto, almeno per la metà del tempo, non più soltanto nel lavoro sul progetto ma in tutta una serie di compiti che riguardano il contesto. Insomma, non ci limitiamo a ricevere una commessa e a realizzare un progetto. Anche tutte le questioni procedurali sono diventate incredibilmente importanti. Come architetto, bisogna saper mettere ordine in una situazione complessa e anche avere un’opinione in merito. A questo proposito, penso che anche per la pratica sia di importanza centrale che le persone in formazione imparino ad affrontare ogni compito con occhio critico. D’altra parte, è necessario anche il know-how legato alla costruzione, un aspetto che, con questo approccio, passa un po’ in secondo piano. Naturalmente resta da chiedersi come chi studia, e un giorno si troverà a lavorare sul campo, a vari progetti, possa acquisire tali competenze.
C’è qualcosa che vorrebbe suggerire per la prossima edizione del Premio Master Architettura della SIA?
Gantenbein: Sono rimasto impressionato dalla qualità dei lavori di Diploma in mostra al S AM. Apprezzo il fatto che l’origine dei singoli lavori non sia sempre e incontrovertibilmente riconoscibile. Sono soddisfatto di questa esposizione, anche perché permette di portare all’attenzione del pubblico il modo in cui il profilo professionale dell’architetta e dell’architetto si sia trasformato. Da questo punto di vista la mostra ha svolto un importante lavoro di divulgazione.
Waeber: Vedrei di buon grado un’istituzionalizzazione del formato. Dalla mostra si evince quanto sia alto il livello architettonico delle scuole universitarie, sia delle SUP che delle università. Fino al 2022 non c’era modo di palesarlo, visto che solo le università potevano accedere al concorso. Tornando regolarmente a organizzare una mostra si contribuirebbe ad alimentare il discorso sulla formazione in architettura offerta dalle scuole universitarie svizzere.
Gantenbein: La realizzazione della mostra è stata anche un felice caso fortuito. Colgo l’occasione per ringraziare, a nome del Consiglio dell’architettura, tutte le scuole che, con così poco preavviso e senza alcuna riserva, hanno sostenuto il progetto. L’essenza del progetto potrebbe forse andare persa se il formato venisse istituzionalizzato, ma dobbiamo avere l’ambizione di portare i nostri temi all’attenzione del pubblico. Magari potremo vedere i lavori premiati esposti nel padiglione svizzero della Biennale di architettura, o forse anche in un altro contesto internazionale. Ciò che conta, in ogni caso, è che per questo evento sia possibile convogliare le sinergie e destare l’attenzione di un ampio pubblico. È un aspetto che reputo più importante della regolarità.
1 Cfr. Maximilian Rimmel, Edition Bibliothek Werner Oechslin (ed.): Luigi Snozzi, 25 Aphorismen zur Architektur. Schwabe Verlag, Basilea 2013